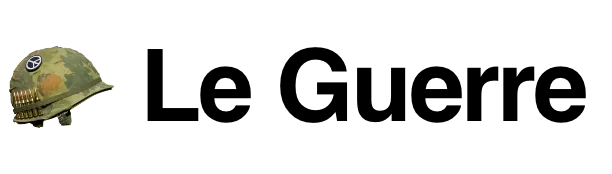Baghdad, i centri abitati sul limitare del deserto iracheno, le bancarelle dei libri, i fabbri, il fiume, durante la guerra non hanno più avuto suoni o colori, erano tutti fatti di polvere.
Sono passati 20 anni, due decenni passati a pensare se quella guerra fosse giusta, o quanto fosse inutile, quanto avrebbe cambiato le sorti della storia e quelle degli uomini che in Iraq hanno continuato a viverci, nella disperazione, alla ricerca di una stabilità.
Non starò qui a girarci troppo intorno. Prima di tutto l’intervento americano in Iraq è stato dettato dalla voglia di vendetta. Poi dallo scopo di lucro. E da una lucida quanto tecnicamente perfetta manipolazione della stampa e conseguentemente dell’opinione pubblica. Un anno dopo l’invasione dell’Iraq, il NYT (in un articolo che potete trovare qui) iniziò a porre seri interrogativi sulla sua stessa cecità nell’aver raccontato qualcosa che non avrebbe dovuto esserci:
“Guardando indietro, vorremmo essere stati più aggressivi nel riesaminare le affermazioni quando sono emerse nuove prove – o non sono emerse”.
La verità è che nei mesi precedenti la guerra, la seconda dopo Desert Storm del 1991, gran parte dell’attuale governo Bush e della stampa si affidò alle informazioni che venivano scientemente passate a Washington da Ahmad Chalabi, uno dei principali antagonisti politici di Saddam Hussein, uomo su cui gli USA avrebbero potuto contare per un’ipotetica ricostruzione che poi non sarà mai stata realizzata per motivi inerenti alla stessa spinta riformatrice della struttura sociale e di potere nel post invasione. Fu Chalabi a parlare per primo di una ipotetica presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Non era l’unico a crederlo, anzi, diciamo che era in ottima compagnia, assieme a lui Bush, Blair, diversi leader del vicino oriente, giornalisti, politici, generali, gente che conta, insomma. Tra suoi “adepti” principali ne bastarono 3 a tirare fuori la parola “guerra” dalle sue supposizioni: il presidente George W. Bush, il suo vice Dick Cheney e il ministro della difesa Donald Rumsfeld; furono loro a decidere di intervenire per liberare l’Iraq da Saddam Hussein nel marzo 2003, partorirono l’idea dell’Iraqi Freedom senza troppa fatica.

A difesa di Chalabi posso solo dire che le sue parole avrebbero meritato qualche ora di riflessione in più sull’opportunità di avventurarsi in un nuovo conflitto, coinvolgendo indirettamente tutti gli alleati europei per un lavoro di peacekeeping che si sarebbe rivelato infruttuoso e uno state building ancora più inutile. Comunque sia, Chalabi era vicino ai più influenti neo-con allora presenti nel congresso, conosceva personalmente Paul Wolfowitz, lo stratega della “dissuasione nucleare” Albert Wohlstetter e il democratico Richard Perle, consigliere politico del segretario alla Difesa sotto l’amministrazione di Ronald Reagan, nonché membro della Commissione della politica della Difesa dal 1987 al 2004.
Ma, come scrive Politico (qui):
“Pensare che un uomo solo – scavalcando il Congresso, la CIA e il Pentagono – possa ingannare una potenza mondiale per invadere una nazione è una comoda fantasia che assolve i veri attori politici dai loro errori nella guerra in Iraq”.
Chalabi fu usato? Non sta a me dirlo, ma nel 2004, una volta superata la fase “shock and awe” dei primi mesi, fu criticato pubblicamente per essere troppo filo-iraniano. Nel 2015, prima di morire, confidò ad un amico giornalista : “L’Iraq è ora peggiore di quanto fosse sotto Saddam”. 8 anni fa d’altronde, oltre ad una situazione di totale caos governativo e finanziario, Mosul, gran parte della zona ad ovest del paese e a nord era diventata territorio di stanza delle nuove minacciose armate nere del Califfato islamico, tutto stava nuovamente precipitando nel terrore e ben pochi degli occidentali erano rimasti per fare scudo ad paese praticamente fallito.
Tornando all’articolo del NYT citato in precedenza, è importante capire il ruolo che ha avuto nella formazione di un’opinione pubblica consenziente e consapevole di ciò che accadeva. Judy Miller fu la giornalista a cui Ahmad Chalabi affidò molte delle sue “soffiate”. Miller scrupolosamente confrontava quanto riferito dall’oppositore di Saddam con ciò che poteva dire la Casa Bianca e dato che le storie coincidevano non ci metteva molto a creare un pezzo interessante per tutti i suoi lettori. Alcuni esempi?
- 20 dicembre 2001, titolo: “L’iracheno che racconta di ristrutturazioni in siti per armi chimiche e nucleari”. Miller presenta un nuovo disertore che si definiva il fabbricante di bombe di Saddam.
- 7 settembre 2002: Titolo: “Gli Stati Uniti dicono che Hussein intensifica la ricerca di parti di bombe atomiche”.
- 13 settembre 2002, titolo: “La Casa Bianca elenca i passi compiuti dall’Iraq per costruire armi vietate”.
- 3 dicembre 2002: “La C.I.A. a caccia di legami con l’Iraq per il vaiolo sovietico”.
Non è quindi un caso che lo stesso NYT abbia fatto ammenda di quanto “propagandato” negli anni precedenti:
“Consideriamo la storia delle armi irachene e del modello di disinformazione come un’attività non conclusa. E abbiamo tutta l’intenzione di continuare a fare un reportage aggressivo per chiarire le cose”.
Già, chiarire le cose.
I fatti sono semplici.
Alle 04:00 del 20 marzo 2003, il corpo principale delle forze della coalizione (Usa e Regno Unito) entrò in Iraq dal Kuwait, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Seguirono le Forze speciali, che avevano iniziato il loro lavoro due giorni prima, e la campagna aerea che colpì Baghdad e altri siti chiave la notte precedente. In poche settimane fu tutto conquistato e iniziò la parte due della storia, quella della politica fallimentare, della strategia inesistente, degli errori grossolani, del coinvolgimento internazionale. Ancora peggiore fu l’utilizzo della forza come stabilizzatore del disordine creato dal vuoto di potere. I soldati americani non potevano e non sapevano svolgere ruoli civili, non sapevano gestire checkpoint, fare guardie nei campi detentivi e trattare prigionieri. Ci pensarono poi milizie private come la Blackwater, con risultati ancor più debilitanti. Ma la sconfitta più grande, dal punto amministrativo si ebbe con la criminalizzazione di tutti coloro che rivendicavano l’appartenenza al partito Ba’ath (quello dell’ex dittatore iracheno). Il Ba’athismo iracheno era uno stile di vita nazionale, culturale e politico e non avrebbe dovuto essere ostracizzato durante la ricostruzione. La de ba’athificazione, voluta tra l’altro da Ahmad Chalabi, metteva tra l’altro in previsione la perdita della pensione per oltre 500mila ex militari, spazzando via una classe politica e segmentando l’intera popolazione, generando instabilità e la formazione di gruppi armati. Non proprio quello che era nelle previsioni al momento dell’inizio delle operazioni.

Il successo militare dei primi mesi portò l’Iraq a diventare un paese fallito, senza contare ovviamente quello che accadde, ad esempio, ad Abu Grahib, una pagina oscura, che racconta più di quello che esprime nelle proprie immagini.
20 anni dopo, con l’attenzione spostata su un altro continente, una situazione strategica totalmente differente e la perdita del controllo di qualsiasi cosa pure in Afghanistan in molti cercano di tracciare una linea. Atlantic lo fa con lo stralcio di un libro di Melvyn Leffler:
Dopo che l’invasione si è trasformata in un’occupazione caotica e disfunzionale e le presunte armi di distruzione di massa dell’Iraq non sono state trovate, Bush ha incaricato il suo direttore dell’Intelligence centrale, George Tenet, di istituire una missione speciale chiamata Iraq Survey Group per indagare su cosa fosse successo a questi armamenti mortali. Il primo direttore del gruppo, David Kay, è apparso davanti alla Commissione Servizi Armati del Senato il 28 gennaio 2004: “Permettetemi di iniziare”, ha ammesso, “dicendo che ci siamo quasi tutti sbagliati” […]
Quello che è certo è che oggi appare chiaro come la superbia e la paura post-11 settembre abbia impedito a Bush jr. di avere cognizione di ciò che stava affrontando. Il suo ideale era quello di esportare l’american way of life nel medio oriente, il risultato che ha ottenuto è stato tragicamente diverso.